Sin dal momento della sua presentazione ufficiale, la 500 non è mai stata considerata un’auto come le altre. Piccola, affascinante, sbarazzina, pronta a mille avventure, beniamina al cinema e fra i vip, la piccola della Casa torinese già dal lancio nel luglio del 1957 ruba la scena anche a ben più blasonate quattro ruote. Ecco una gallery delle notizie più curiose che la riguardano.
Il prototipo fa i primi passi
I paparazzi immortalano i primi passi, sulle strade intorno a Torino nella primavera del 1957, del prototipo della futura Nuova 500. Il cofano posteriore con le numerose griglie di sfogo verrà poi semplificato.
Il debutto con le miss
Luglio 1957: ecco la presentazione ufficiale, articolata in un lunghissimo corteo di vetture a capote aperta, con tanto di miss e mazzo di fiori, che da Mirafiori si snoda in diversi angoli di Torino.
Professore e manager
Vittorio Valletta, il grande economista voluto da Giovanni Agnelli nel 1921 a riorganizzare la Fiat. Ai tempi della 500 era sia presidente sia amministratore delegato.
Capacità indiscutibili
L’ingegner Dante Giacosa, incaricato da Valletta di ideare la 500, intervistato nel 1957 da Gigi Marsico, della Rai di Torino, nel corso del servizio esclusivo dedicato al processo produttivo e all’industrializzazione.
La scocca per i carrozzieri
La scocca della prima serie, senza i cofani, le portiere e le fiancate (che erano un tutt’uno coi parafanghi), così come viene fornita direttamente dalla Casa torinese ai carrozzieri affinché possano allestire le loro versioni fuoriserie.
Il penta Campione prova la piccola
Cinque volte iridato in Formula 1 (1951, 1954, 1955, 1956 e 1957) e una passione per qualsiasi mezzo con le ruote: l’asso argentino Juan Manuel Fangio accetta col sorriso l’invito a testare una 500 della scuderia Sant Ambroeus. “Piccola e spartana ma molto divertente da guidare”, dirà alla fine del test.
Osservazione molto regale
Tra gli estimatori d’alto rango del “cinquino” anche il re Leopoldo del Belgio, che si mostrò molto interessato alla piccola torinese tanto da chiedere di poterne provare una a Torino.
Benedizione urbi et orbi
Il cardinale Giovanni Battista Montini, futuro papa Paolo VI dalla fine del 1963, rimase ben impressionato dalla compattezza della 500, che gli ricordava – parole sue sante – la Topolino.
Una bellezza seducente
Saint-Vincent 1957:una meravigliosa Virna Lisi scende dalla 500 dopo aver effettuato alcuni giri su e giù per i tornanti intorno al paese della Valle d’Aosta ed esclama: “Che divertente!”.
Motoscafo fuoriserie
Tra le varie fuoriserie realizzate sulla base della Fiat 500, molto particolare è quella che Frua presenta al Salone di Torino nel 1957, simile anteriormente a un motoscafo per il notevole arretramento dei fari.
Il gentleman e la Zagato
Ovidio Capelli, uno dei gentleman driver più rappresentativi degli anni Cinquanta, qui ripreso con la 500 berlinetta di Zagato nel 1957, con caschetto e 24 ore; trionfa nel campionato italiano classe 500 GT.
Col bicilindrico della Guzzi
Nel 1958 Fiat e Guzzi valutano la possibilità di equipaggiare la 500 con un 2 cilindri a V di 90°. Progettato da Giulio Cesare Carcano, sviluppava 21 CV a 5300 giri/min e faceva volare il “Cinquino” a 115 all’ora.
Giocattolo per il mare
Ugo Tognazzi si innamora subito della 500 e ne compera una per lasciarla nella sua residenza estiva in un borgo vicino a Pomezia, che oggi prende il nome di Villaggio Tognazzi.
Aerodinamica da record
Questa 500 monoposto, ideata dalla Pinin Farina e guidata da Mario Poltronieri, ottiene numerosi record di velocità durante i test effettuati a Monza nel settembre del 1958.
Lotta serrata ma vincente
L’italiano Arturo Brunetto e l’argentino Alfredo Frieder con la Fiat 500 Sport, festeggiati all’arrivo della vittoriosa Liegi-Brescia-Liegi del 1958, dove battono Berkeley, Isetta e 2 CV.
A Monza che record
La 500 Abarth ottiene il record di velocità sul circuito di Monza, coprendo la bellezza di 18.186 km alla velocità media di 108,52 km/h tra il 13 e il 20 febbraio 1958, girando giorno e notte.
Sedili in vimini, una sciccheria
Si chiama 500 Jolly la spiaggina costruita dalla carrozzeria Ghia dal 1957 al 1965. Tra i suoi estimatori figurano anche personaggi del calibro di Aristotele Onassis, Yul Brynner, Enrico Berlinguer e Silvio Berlusconi.
Debutto col botto
Alla 12 Ore di Hockenheim (26 maggio 1958) quattro 500 Sport si piazzano ai primi quattro posti di categoria, con i rispettivi equipaggi Levy-Jeser, Nicosia-Leto di Priolo, Messedaglia-Antolini, Leto di Priolo-Prandoni.
Occhi di rana per gli yankee
Dal dicembre del 1957 le 500 vengono esportate negli Usa via mare, a bordo dell’Italterra. Si distinguono per i grossi fanali anteriori, che danno ai musetti una simpatica aria da ranocchietta.
L’armatore e lo statista
Estate 1959: Aristotele Onassis ospita sul suo yacht “Cristina O.” nientemeno che Sir Winston Churchill. Per spostarsi a terra usano una 500 spiaggina costruita da Savio su disegno di Mario Boano.
Mille ore a Roma tutte d’un fiato
La 500 D a Roma davanti al monumento del Milite Ignoto nel corso della “Mille Ore in città”, prova di durata di Quattroruote tra giugno e luglio 1960. Tra i dati registrati, spicca quello dei colpi di frizione, alla fine ben 387.389.
Il parabrezza si accorcia
Originale la linea della spider che la Viotti presenta al Salone di Torino 1961 (per mano di Rodolfo Bonetto), con fanaleria simile a quella dell’Austin-Healey Sprite e dal curioso parabrezza, che è parzialmente abbassabile.
Spicca il volo con l’ alitalia
Il Douglas DC-7F è il cargo scelto dalla nostra compagnia di bandiera per trasportare, agli inizi degli anni Sessanta, le 500 D in tutte le concessionarie europee.
Piace molto pure in austria
In Austria la 500 viene prodotta dalla Steyr-Daimler-Puch. Si tratta di una versione della Nuova 500 costruita su licenza della Fiat in varie cilindrate e allestimenti dal 1957 fino al 1973.
Alberto Sordi fa “boom”
Alberto Sordi, Gianna Maria Canale e la 500 D sul set de “Il boom” del 1963 diretto da Vittorio De Sica. Nel film Sordi è costretto a vendere un occhio per riuscire a pagare tutti i suoi debiti.
Operazione spinterogeno
Sono 55 gli elettrauto che vengono coinvolti, a loro insaputa, nell’inchiesta di Quattroruote del 1963, dove viene simulato un guasto per testarne la perizia. I risultati? Quasi tutti promossi a pieni voti.
Guida a destra per sua maestà
L’interno di una 500 così come veniva allestita per i mercati del Regno Unito. Oltre alla guida a destra era naturalmente previsto un contachilometri tarato in miglia.
Sono Tont, James tont
In “James Tont Operazione U.N.O.” (regia di Bruno Corbucci, 1965) Lando Buzzanca affronta mille peripezie con una 500 D che ha anche le mitragliatrici che fuoriescono dallo sfogo dell’aria sotto il lunotto.
Qui base Scott, nessun problema
Grazie alla proverbiale affidabilità e, soprattutto, al raffreddamento ad aria, la 500 D viene scelta come veicolo d’appoggio nella base antartica Scott, con l’aggiunta del gancio di traino e delle catene.
Combattente nel sessantotto
Una 500 F protagonista (suo malgrado) durante un corteo pacifista e relativo sit-in per le strade di Milano nel 1967, che purtroppo un paio di ore dopo sfocerà in uno scontro piuttosto violento con la polizia.
Nevica? non c’è alcun problema
Milano, Bastioni di Porta Venezia, inverno 1963: al verde del semaforo scatto felino della 500 e della 600 che, in barba alla neve che inizia a scendere fitta, affrontano le insidie della città anche senza pneumatici chiodati.
Sul tettoc’è sempre posto
Un’automobilina a pedali, una damigiana (da 54 litri), un passeggino, una griglia per il barbecue, una valigia, uno scatolone con palla da pallavolo e abat jour che sporge, un vaso di gerani: ci sta proprio tutto sul tetto della 500!
Milano-napoli in 9 ore e 16 minuti
Il 4 ottobre 1964 si ultima l’Autostrada del Sole e Quattroruote la percorre con la Fiat 500 D: al volante il collaudatore Giulio Pusinanti, al suo fianco si alternano Rachele Regalia e Barbara Antonini, studentesse universitarie.
Un disegno d’autore per la piccola
Artista attivo in area torinese, Nino Aimone frequenta lo studio di Felice Casorati e si lega al gruppo dei giovani pittori, soprattutto informali, del capoluogo subalpino. Per la nascita della 500 realizza questo splendido manifesto dove l’utilitaria viene festeggiata da tutti, giornalisti e operatori della TV compresi.
Concorso a premi multimilionario
La 500 spopola e molte associazioni e scuderie iniziano a organizzare eventi e gare che l’abbiano come protagonista. Come l’Automobile Club di Roma, che organizzò il 500 Match, gara di regolarità e velocità a tracciato chiuso, con un montepremi totale di ben 12 milioni di lire. Nel 1958 le prime due prove vennero vinte da Antonio Thellung.
Una semplicità disarmante
Per le officine più attrezzate il top è un ponte a due colonne, ma anche con un semplice cric idraulico i tecnici possono operare sulla meccanica della 500 con relativa facilità, persino se si tratta dello stacco del gruppo frizione-cambio.
Il “Cinquino” marchiato NSU
Realizzata dalla carrozzeria Weinsberg nell’omonima località tedesca, la 500 NSU venne costruita in 6190 esemplari dal 1959 al 1963in due versioni, Coupé (a sinistra) e Limousette, tutte e due disponibili col tetto apribile di tela.
Una cadetta per la polizia
L’agilità della 500 è proverbiale. Ecco perché negli anni Sessanta la polizia decise di utilizzarne un paio di esemplari sulle strade anguste dell’isola di Capri, per specifico pattugliamento.
Alla magliana si pensa in grande
Negli anni Sessanta molte concessionarie si strutturano per poter ospitare le auto in pronta consegna vicino alla zona di assistenza, come questa nella zona Eur di Roma, dove fiammanti 600 e 500 D attendono il loro nuovo proprietario.
Un cacciavite e si parte
Una tipica scena in un’officina alla fine degli anni Cinquanta: il cofano posteriore smontato per poter operare nel migliore dei modi sul carburatore della 500, con un solo cacciavite.
500 batte tram con un bel 4-0!
Nell’ottobre del 1965 Quattroruote conduce un’inchiesta mettendo a confronto spesa e tempo per muoversi a Milano coi mezzi pubblici o con l’auto. Sui 4 itinerari studiati, vince sempre la 500.
Revisione regolare
Una Fiat 500 D in fase di controllo della frenata posteriore su uno dei primi banchi a rulli che vengono montati presso le Motorizzazioni provinciali per le revisioni periodiche.
L’albarella della Savio
Dopo aver ideato la Jungla su base Fiat 600, la Savio nel 1967 ritenta con l’Albarella, che adotta la meccanica della Fiat 500. La carrozzeria è simile a quella della Jungla. Rimarrà però allo stadio di prototipo.
Francis Lombardi e la Coccinella
Tra le varie fuoriserie che la Francis Lombardi di Vercelli allestì negli anni di produzione della Fiat 500, spicca la Coccinella del 1964, che in alcuni elementi della parte posteriore ricorda la Fiat 850 Coupé.
La giannini economica
Nel 1974 la Giannini si rende conto della congiuntura poco favorevole e decide di ridurre la cilindrata della 500 R: nasce la 350 EC, col bicililindrico ridotto a 390 cm3 e potenza di 16 CV (anziché 18).
Lucertola a sei ruote
La Ferrario di Albavilla (Como) allestisce nel 1973 la Lucertola 6×4 (tre assi con quattro ruote motrici posteriori) con motore della 500 e cambio della 600 su telaio tubolare con sospensioni anteriori indipendenti.
La fuoristrada della Ferves
La torinese Ferves (Ferrari veicoli speciali)presenta al Salone di Torino nel 1966 la Ranger, una piccola fuoristrada anche 4×4, su base Fiat 500, che rimarrà in produzione fino al 1971.
Una monella per vignale
Esordisce nel 1967 la piacevole versione spider della Vignale, battezzata Gamine (monella, in francese), con un look retrò; sarà costruita in poche centinaia di pezzi fino alla chiusura dell’azienda nel 1974.
Taxi nella settimana della moda
Lo scorso anno la Fiat ha ideato un’iniziativa per i clienti del car sharing “Enjoy”: 500 storiche (con autista) al posto delle solite “moderne” per le più belle vie di Milano, nella settimana della moda.
Un dragster col 4 cilindri
Una 500 D con motore bialbero della 124, coppa dell’olio Giannini e carburatori doppio corpo: vero e proprio dragster allestito nel 1967, quello nella foto qui accanto, per poter gareggiare a Vallelunga. È uno dei tanti esperimenti per le corse fatti sulla base della piccola utilitaria.
Ecco dove è finita
La 500 utilizzata da Juan Manuel Fangio (vedi pag. 40), che era di Giorgio Matteo Gregori della scuderia Sant Ambroeus, è stata ritrovata e restaurata grazie alle cure di Francesco Viola.
Da modena in India…
Tra le varie cronache di viaggi documentati da Quattroruote, c’è anche quello di tre giovani modenesi che nel 1969 lasciano la loro città su una 500 diretti in India, percorrendo in tutto oltre 30 mila km e consumando olio e benzina pari a 125 mila lire.
…e da torino a pechino
Danilo Elia e Fabrizio Borserio nel 2005 percorrono oltre 20 mila km da Torino a Pechino. Lo scopo è portare la loro 500 R in piazza Tien An Men, per la prima volta via terra dall’Italia. Nel corso del viaggio schivano anche una rivolta in Uzbekistan.
Altogradimento
Renzo Arbore è da sempre un fan scatenato della 500: “La mia si chiama Giuseppina in onore di mia madre. È semplicemente geniale, tipico esempio del made in Italy”.
Le avventure di Manfredi
Nello serie televisiva “Linda e il brigadiere” (1997) l’ex poliziotto Nino Fogliani (alias Nino Manfredi), padre di Linda (Claudia Koll) riesce a districare i “casi” più difficili a bordo di una Fiat 500.
L’utilitaria del presidente
Anche Sandro Pertini, il presidente della Repubblica più amato, non resistette al fascino della 500. Una curiosità; non avendo la patente, faceva guidare sua moglie Carla Voltolina durante gli spostamenti.
Grande festa per il mondiale 1982
Zoff, Bergomi, Cabrini, Collovati, Gentile, Scirea, Oriali, Tardelli, Conti, Rossi, Graziani: è la formazione che trionfa al “Santiago Bernabeu” l’11 luglio 1982, conquistando il terzo campionato del mondo di calcio. In strada, in tutta Italia, si fa festa, anche in 500.
Luigi & Guido, amici di saetta mcqueen
Nel film “Cars” (Pixar, 2006), tra i personaggi indimenticabili ci sono anche gli amici di Saetta McQueen: Luigi (a sinistra), una Fiat 500 del 1959 che gestisce il negozio di pneumatici, col suo inseparabile amico Guido, un piccolo carrello elevatore.
Le avventure di lupin III
Ecco Arsenio Lupin III, in compagnia dei fidi Daisuke Jigen e Goemon Ishikawa XIII, a bordo dell’inseparabile Fiat 500 D, che è la compagna nelle scorribande del simpatico ladro disegnato da Monkey Punch nel 1967.
Sotto il vestito, ancora una 500!
Presentata il 4 luglio 2007, l’attuale Fiat 500 ripropone molte soluzioni stilistiche dell’omonima antenata che esordì sessant’anni fa. Tra gli accessori a richiesta, anche il telo copriauto, che ricalca il disegno della prima serie del 1957.
 È il primo corso professionale di specializzazione dedicato al restauro e all’universo dell’Heritage nel settore dell’automobile. Un gruppo di quindici giovani (con già una adeguata preparazione di meccanica, meccatronica ed elettrotecnica), scelti tra una lunga lista di aspiranti ammessi alle selezioni, saranno impegnati da oggi e per tutto il mese di luglio in un ciclo di lezioni (per loro il corso è gratuito) in Auditorium o nell’Officina storica della Collezione Mazzocchi.
È il primo corso professionale di specializzazione dedicato al restauro e all’universo dell’Heritage nel settore dell’automobile. Un gruppo di quindici giovani (con già una adeguata preparazione di meccanica, meccatronica ed elettrotecnica), scelti tra una lunga lista di aspiranti ammessi alle selezioni, saranno impegnati da oggi e per tutto il mese di luglio in un ciclo di lezioni (per loro il corso è gratuito) in Auditorium o nell’Officina storica della Collezione Mazzocchi. Il corpo docente, oltre ai giornalisti di Ruoteclassiche, si avvale di un ventaglio di personalità con alto grado di specializzazione nel mondo delle classiche. Si andranno così ad esaurire e comprendere tutte le aree tematiche che definiscono l’universo della passione per i veicoli storici: collezionisti, esperti di aste, ricercatori, organizzatori di eventi, docenti di istituti di restauro, giurati provenienti dai maggiori concorsi d’Eleganza del mondo.
Il corpo docente, oltre ai giornalisti di Ruoteclassiche, si avvale di un ventaglio di personalità con alto grado di specializzazione nel mondo delle classiche. Si andranno così ad esaurire e comprendere tutte le aree tematiche che definiscono l’universo della passione per i veicoli storici: collezionisti, esperti di aste, ricercatori, organizzatori di eventi, docenti di istituti di restauro, giurati provenienti dai maggiori concorsi d’Eleganza del mondo.


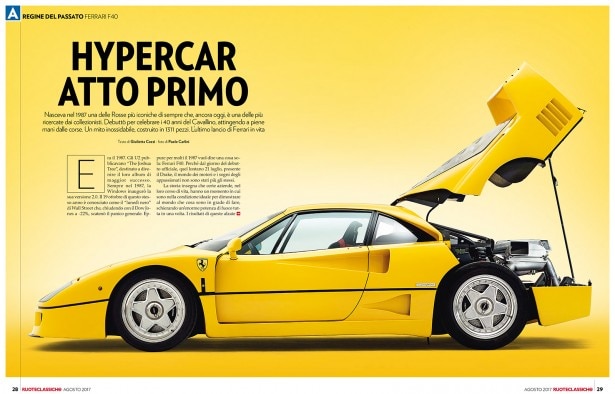 Completano la sezione Automobili, un suggestivo “Test a test” tra Fiat 1400 Elaborata Abarth (1950) e Alfa Romeo 1900 TI Super (1955), la Peugeot 406 3.0 V6 Coupé (1999, “Impressioni”), l’Audi TT RS (“Classiche domani”) e la panoramica dei mezzi della collezione privata del conduttore televisivo Gianni Ippoliti. Tra i “Veicoli commerciali”, sotto la lente il Fiat 508 3 Marce Furgoncino del 1933.
Completano la sezione Automobili, un suggestivo “Test a test” tra Fiat 1400 Elaborata Abarth (1950) e Alfa Romeo 1900 TI Super (1955), la Peugeot 406 3.0 V6 Coupé (1999, “Impressioni”), l’Audi TT RS (“Classiche domani”) e la panoramica dei mezzi della collezione privata del conduttore televisivo Gianni Ippoliti. Tra i “Veicoli commerciali”, sotto la lente il Fiat 508 3 Marce Furgoncino del 1933. La nuova “Copertina d’autore” è probabilmente l’ultima opera di Tom Tjaarda, al quale dedichiamo un intenso ricordo con un’intervista alla moglie Paola Bronzino e all’amico Filippo Disanto.
La nuova “Copertina d’autore” è probabilmente l’ultima opera di Tom Tjaarda, al quale dedichiamo un intenso ricordo con un’intervista alla moglie Paola Bronzino e all’amico Filippo Disanto. La “Tecnica” entra nel merito del ponte De Dion, le “Vendita all’asta” si sofferma sui recenti incanti di Goodwood (Bonhams) e di Montecarlo (Artcurial).
La “Tecnica” entra nel merito del ponte De Dion, le “Vendita all’asta” si sofferma sui recenti incanti di Goodwood (Bonhams) e di Montecarlo (Artcurial).



